 |
Quello che il fascismo ci aveva insegnato
di
Rinaldo Battaglia *
“Quello che ci avevano insegnato nella nostra giovinezza era tutto sbagliato. Non bisognava credere, obbedire, combattere. Non bisognava che l’obbedienza fosse cieca, pronta e assoluta. Non bisognava che libro e moschetto fosse il fascista perfetto”.
Così scriveva il vicentino ‘sergente nella neve’ e poi IMI convinto Mario Rigoni Stern nelle sue analisi e memorie (in ‘Il coraggio di dire no’ - Einaudi, 2013 - e nella ‘Vita, guerre, libri’ - Priuli & Verlucca, 2016).
‘Quello che il fascismo ci aveva insegnato era tutto sbagliato’.
Si poteva essere uomini del regime, si poteva essere militari e soldati in nome della Patria, ma poi – quando si comprendeva di essere dalla parte sbagliata, dalla parte di chi predicava e collaborava ora attivamente alla repressione, alle torture, alle stragi, ai rastrellamenti anche contro bambini e donne inermi – poi si poteva, volendolo, cambiare. E scegliere di non aderire più, dopo l’8 settembre 1943, alla Repubblica di Salò, il ‘continuum’ del regime del ventennio di Mussolini. Scegliere di non restare dalla ‘parte sbagliata’, dalla parte dei carnefici, dalla parte di chi serviva convintamente l’invasore nazista, dalla parte di chi aveva allevato i giovani all’odio razziale, al ‘dovere della guerra’, alla differenza tra razze superiori e razze inferiori, tra ‘spazi vitali’ di altri che dovevano diventare nostre terre per la gloria e vanità del Duce.
Anche se era la lontana Russia ed enorme il costo necessario in vite umane. Sappiamo bene che dei 229.000 uomini lì spediti, prima come CSIR e poi ARMIR, neanche la metà tornarono a casa vivi. Vivi ‘per fuori’ almeno, perché ‘per dentro’ erano tutti carichi di croci e cicatrici.
Ecco il motivo per cui non si possono, oggi, parificare Resistenza e Salò, fascismo e antifascismo. Non è storicamente corretto e umanamente accettabile. Per quanto si voglia purificare Caino ed abbassare dal podio Abele, nella Storia e per la Storia Caino sarà sempre Caino ed Abele sempre Abele: uno dalla parte sbagliata e l’altro dall’altra riva del fiume.
L’8 settembre 1943 in Italia divenne quel fiume e molti scelsero la riva che più sentivano la loro. In linea coi propri principi, in coerenza coi propri valori. Chi da una parte e chi dall’altra.
Poco lontano da casa mia, davanti alla chiesa di Crespadoro nella piazzetta del paese, massacrato dai nazifascisti nel luglio del 1944, esiste da 50 anni un monumento. Semplice e vero, autentico. Come solo le genti della mia terra vicentina: semplici, vere, autentiche. E con una scritta di poche parole che valgono più di libri di mille pagine: “per onorare quanti sacrificarono la loro vita per farcene vivere una migliore”.
Tra quelle vite che oggi stanno ’vivendo in modo migliore’ c’è anche la mia, una vita figlia della generazione successiva. Tra quelle vite – invece - che si sacrificarono, sapendolo di sacrificarsi, affinché altri potessero vivere meglio vi era anche quella di Mario Molon, passato alla Storia della mia terra col nome di battaglia di Ubaldo.
Ubaldo o, meglio, Mario Molon, non era nato – per così dire – eroe. Pensate: venne al mondo nel marzo del 1919, quattro mesi dopo la fine della Grande Guerra. Concepito in tempo di guerra ma nato in tempo di pace. Due anni e otto mesi dopo, il fascismo di Mussolini arrivò al potere e l’Italia cambiò. In peggio.
Quando Mario iniziò la scuola si studiava su unico libro, un unico testo deciso dal regime. La maestra doveva essere allineata perché, se non lo fosse stata non avrebbe mai potuto insegnare. Poi quando, nell’aprile 1926, compì 7 anni eccolo inquadrato, come tutti gli altri coetanei, nell’Opera Nazionale Balilla, per apprendere la giusta “educazione culturale, spirituale e religiosa della gioventù", e conoscere in profondità la "storia della cultura fascista". Due anni dopo, nel 1928, imparò che era obbligatorio a scuola anche il saluto romano, già adottato nelle uscite pubbliche.
Quando arrivò ai 15 anni e già lavorava a Recoaro un giorno (il 24 agosto 1934) venne a sapere che per il Duce ‘la Nazione doveva essere pronta alla guerra non domani, ma oggi.” E quindi proseguì nel suo percorso – deciso da altri – per diventare soldato, ossia carne da macello per la gloria e la vanità sempre di altri. Come quelli della sua generazione. Allevato dal fascismo, per il fascismo, nell’interesse del fascismo.
Niente da meravigliarci quindi se, nel 1939, fosse a militare, mentre Hitler e Mussolini a Monaco il 22 maggio si sposavano e firmavano il ‘patto d’acciaio’, la dichiarazione di guerra al mondo da parte della Germania nazista e dell’Italia fascista. Guerra che da noi arriverà il 10 giugno 1940 e che regalerà a Mario - anziché il congedo dopo la leva, e il ritorno nella sua Recoaro dalla giovane moglie Assunta - il prosieguo obbligato, nel corpo dei bersaglieri.
E qui il carattere non allineato al fascismo, malgrado la scuola ricevuta, in Mario iniziò a farsi sentire. E qualche mese di carcere militare a Gaeta, lo confermarono. Poi Mussolini volle la Russia e il suo nome ugualmente fu inserito l’8 luglio 1941 tra i primi destinati a quella campagna. Vi rimase solo un anno perché nell’estate ’42 venne ferito e rimpatriato con biglietto urgente verso l’ospedale militare di Riccione. Sotto certi aspetti fu una fortuna, perché i suoi commilitoni pochi mesi dopo vissero la grande disfatta nel gelo, bene raccontata proprio dal nostro Mario Rigoni Stern.
E mentre l’Italia veniva sconfitta dappertutto, Nord Africa e Russia, Mario Molon, ristabilitosi ritornava al suo posto tra i Bersaglieri del 5° Rgt di stanza a Pinerolo. E fu in questo contesto che visse l’8 settembre. E fece la sua scelta. Era stato creato dal fascismo, allevato per la guerra, educato al pensiero unico, con unico dio e padrone. Ma non poteva più accettarlo e, come tanti, comprese che “quello che il fascismo aveva loro insegnato era tutto sbagliato’. E lo fece in prima persona, attivamente, mettendo in gioco la sua vita. Ossia tutto.
Aveva una giovane sposa a Recoaro, aveva una piccola figlioletta Caterina da accudire e a cui pensare, aveva una vita davanti, ma non poteva delegare ad altri il destino del suo futuro e dei suoi cari. Aveva solo 24 anni ma scelse di sacrificare la sua vita affinché altri potessero viverne una migliore, una migliore di quella che lui aveva vissuto, sotto il fascismo, per il fascismo, nell’interesse del fascismo. E passò dall’altra parte della riva, sapendone bene i rischi.
Già ad ottobre fece parte dei ‘ribelli’ di Bosco di Marana, sempre nella sua e nostra terra. Due/tre mesi dopo eccolo parte viva dei partigiani di Malga Campetto, tra i gruppi di Resistenza in zona più attivi e più bersagliati dai fascisti locali. In breve, divenne ‘Ubaldo’ e punto di riferimento per molti. Già a marzo ’44 è capopattuglia e la sua pattuglia, appartenente al btg. "Stella" della "Garemi", tra le più attive e combattive. Stimato tra i partigiani e temuto e quindi ‘cercato’ dai fascisti. Con qualsiasi mezzo e tra questi anche le delazioni, i tradimenti per denaro o che altro, erano previste.
Ubaldo sacrificò la sua vita, per farcene vivere una migliore, il 5 giugno 1944. Aveva quel giorno 25 anni, una moglie e una figlia. E il suo destinò si incrociò con quello di un altro eroe partigiano, Illido Garzara, nome di battaglia ‘Sgancia’.
Questi era ancora più giovane: classe 1924. Originario di Fiesso d’Artico, dopo l’8 settembre a 19 anni, anziché la RSI di Salò, scelse la pianura del Brenta e poi le colline vicentine tra i partigiani locali, dove era più facile lottare contro i nazifascisti. Con un gruppo di altri 11 compagni della Riviera del Brenta, si unì già a marzo ‘44 alla Brigata Vicenza, seguendo anche le indicazioni di Sebastiano Favaro un antifascista di prim’ora, molto stimato a Fiesso d’Artico e in contatto dopo l’8 settembre ’43 con Giuseppe Marozin (tenente Vero) e il suo gruppo. Illido non voleva restare dalla parte sbagliata e scelse così anch’egli di sacrificare convintamente la sua giovane vita per farcene vivere una di migliore.
In quel maledetto 5 giugno, il giorno dopo che Roma era stata liberata – grande sconfitta per il fascismo di casa nostra - ed il giorno prima che in Normandia arrivasse il D-Day con obiettivo la sconfitta finale del nazismo – Sgancia e Ubaldo vennero uccisi assieme. Due storie diverse, ma un unico punto denominatore: la lotta al nazifascismo in nome della libertà, della democrazia, di una vita migliore. Tutti concetti che loro due non avevano mai prima vissuto, conosciuto, sperimentato. Libertà, democrazia erano parole allora astratte nel vocabolario italiano, di difficile traduzione nella vita di tutti i giorni qui da noi. Eppure, eppure decisero così.
“Sgancia” era stato preso prigioniero in un vasto rastrellamento nazifascista nella zona di Chiampo. Quella mattina alla locale stazione prima della partenza del treno delle 7,10 che doveva trasferire 35 giovani reclute della GNR in altre sedi, 6 partigiani della Brigata “Vicenza” di ‘Vero’ Marozin, comandati da “Ciccio” (Rino De Momi) erano riusciti a bloccare il convoglio e ‘rapire’ quei giovani portandoli direttamente sulle colline attorno. Molti di loro in breve diventeranno partigiani. Il tutto molto probabilmente – se non certamente - con la collaborazione ‘attiva’ del maresciallo dei Carabinieri di Chiampo, Matteo Scauri, che pagherà quest’azione con un biglietto di sola andata verso i lager della Germania, da cui più non farà ritorno. Per i fascisti di zona, il maggiore Paolo Antonio Mantegazzi (o Mentegazzi in alcuni documenti), fu un’offesa, un affronto davanti agli occhi degli alleati nazisti.
Bisognava rispondere, in sinergia coi soci di Hitler. E in questo terribile rastrellamento di tutto e tutti, verso mezzogiorno, che in zona Mistrorighi vennero sorpresi alle spalle quattro partigiani, in quella zona solo di passaggio con destinazione Durlo. Due riuscirono a fuggire, gli altri due no. Erano “Sgancia” e “Ceseta” (Lionello Doni anch’egli arrivato lì con Sgancia da due/tre mesi). Portati con violenza subito a Chiampo, vennero affidati alle cure di Mantegazzi e dei suoi bracci operativi, Giovan Battista Polga e Otello Gaddi, il meglio del peggio del fascismo in valle.
Vittoriano Nori (in “Arzignano nel vortice della guerra”) e Giancarlo Zorzanello (in ”Archivio storico della brigata Stella - 1°) oltrechè il grande storico locale Giorgio Fin (in più libri ma soprattutto in “Teresa Peghin”) raccontano che i due partigiani vennero “per due ore li maltrattati nella pubblica piazza sottoponendoli persino a finte fucilazioni contro il muro del municipio” I fascisti “li rinchiusero poi in una cella finché, verso le cinque del pomeriggio, furono prelevati dai tedeschi e portati ad Arzignano dove furono sottoposti ad interrogatorio. Per le loro risposte contraddittorie il comandante tedesco si arrabbiò molto, ma - dicono le testimonianze - non toccò i prigionieri neppure con un dito. Alla fine, li licenziò e li fece rinchiudere in una cella”.
Qui poco dopo, in quella cella, arriverà anche Ubaldo. Con la sua pattuglia in quel pomeriggio si era fermato ”in un bosco nei pressi della località Calpeda di Arzignano.”
“Purtroppo – scrive Giorgio Fin - al passaggio per Restena la pattuglia fu notata da una donna, Maria Boschetti, che sarebbe divenuta poi la famosa e famigerata "Katia". Costei corse subito ad Arzignano ad avvisare le autorità fasciste. Fu così che verso le ore 18 quando “Ubaldo” entrò da solo nella casa di Giovanni Lovato per chiedere acqua e viveri per i propri partigiani, accampati poco lontano, l’abitazione fu subito circondata da una quindicina di militi fascisti. “Ubaldo” si difese con le armi che possedeva, una pistola e alcune bombe a mano, ma venne catturato. I suoi compagni, sentiti gli spari, si misero in salvo. Con “Ubaldo” vennero fatti prigionieri anche il padrone di casa e altri tre giovani che si trovavano lì per caso. I fascisti, prima di lasciare la contrada Calpeda, diedero fuoco alla casa del Lovato e al fienile, razziarono le galline e, per divertirsi, uccisero persino il maiale”.
E così verso sera, dopo terribili interrogatori, “legati mani e piedi, furono gettati in quella cella ad Arzignano dove erano rinchiusi anche gli altri due, "Sgancia" e "Ceseta”. Tra i prigionieri "Ubaldo" era quello che portava maggiormente i segni dei maltrattamenti subiti”.
“Erano lì rinchiusi da circa un’ora, quando riapparve il capo dei fascisti, il maggiore Mantegazzi, che scelse Garzara, Molon e Lovato e li fece portare via. Gli altri quattro furono condotti a Vicenza, imprigionati e il 27 giugno avviati in un campo di concentramento in Germania. Torneranno, provati dalle sofferenze, solo dopo la Liberazione. I partigiani Garzara e Molon, con Giovanni Lovato furono invece ricondotti a Chiampo per dare una lezione esemplare al popolo di questa città e della Valle. Verso le 20.30 il Mantegazzi, deciso ad ucciderli, fece venire il cappellano di Chiampo don Giovanni Brizzi perché li confessasse, pretendendo che lo facesse in pubblico.
Don Giovanni invece, coraggiosamente, li confessò ad uno ad uno in un’altra stanza e poi per salvarli, osservò che quei poveretti non potevano essere condannati senza processo. Il maggiore fascista imbastì allora un processo–farsa, in cui egli fungeva da giudice e da accusatore, e che dopo urla, schiaffi e sevizie si concluse inevitabilmente con la condanna a morte dei tre. Don Brizzi intervenne ancora, ma riuscì ad ottenere la grazia solo per Giovanni Lovato. Non si sa se questo è stato un bene per lui, perché fu mandato in Germania, nel campo di Buchenwald, ove morì il 17 febbraio 1945. Mario Molon “Ubaldo” e Illido Garzara “Sgancia” furono quindi condotti alla Calcara, sotto il campanile di Chiampo, dove furono fucilati alle 21,30 di quel tremendo 5 giugno 1944”.
“Quello che ci avevano insegnato nella nostra giovinezza era tutto sbagliato. Non bisognava credere, obbedire, combattere. Non bisognava che l’obbedienza fosse cieca, pronta e assoluta. Non bisognava che libro e moschetto fosse il fascista perfetto”.
Bisognava scegliere e decidere da che parte stare.
Ubaldo e Sgancia decisero di opporsi e sacrificare convintamente la loro vita affinché altri – cioè noi, le generazioni successive – potessimo viverne una migliore. Questa è stata la Resistenza partigiana e oggi nell’81° Anniversario di quel sacrificio e nell’80° Anniversario della Liberazione del 25 Aprile noi dobbiamo onorare tutti coloro che sacrificarono la loro vita per una vita degli altri migliore, libera, democratica in cui non ci sia spazio all’odio razziale, al ‘dovere della guerra’, alla differenza tra razze superiori e razze inferiori, ai Binari 21 e alle Risiera di San Sabba. Abbiamo già dato ed è nostro dovere ricordarlo in eterno. Costi quel che costi, perché come diceva il Nobel Jose’ Saramago ‘noi siamo la memoria che abbiamo’. Tutto il resto è propaganda, forse solo immondizia.
È più che mai giusto, infatti, per sempre ‘onorare quanti sacrificarono la loro vita per farcene vivere una migliore’.
Talvolta non riesco a capire come, dopo 80 anni, ci siano in Italia dubbi in merito e confondere le idee tra chi era dalla parte giusta e chi dalla parte sbagliata.
E basterebbe conoscere alcune parole di un giovane partigiano di allora (Italo Calvino) per rendersene conto:
"Dietro il milite delle Brigate nere più onesto, più in buonafede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'Olocausto; dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, chè di queste non ce ne sono”.
Ubaldo e Sgancia erano tra questi, tra quelli dalla parte giusta. Per questo oggi e sempre, senza se e senza ma, vanno onorati.
5 giugno 2025 – 81 anni dopo
* Coordinatore Commissione Storia e Memoria dell'Osservatorio
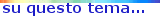 
Dossier
diritti
|
|

