 |
Ho visto No other land: sullo schermo il dolore e la resilienza
di
Rossella Ahmad
Il momento non era dei migliori, ma la programmazione a Napoli è limitata e ad essa vengono riservate piccole stanzette con un capienza massima di cinquanta posti. Le sale grandi sono dedicate ovviamente al divertimento per le masse. E la proporzione è sempre la stessa, quella del parlamento cileno all'indomani del golpe militare: nove uomini che si alzarono in piedi in segno di protesta contro una moltitudine di plaudenti.
E quindi ho visto No other Land, ed ho ricevuto il solito pugno nello stomaco che incassi quando ti trovi ad osservare, impotente, l'epitome sulla terra della violenza impunita. Conosco quella violenza, quindi ero preparata. Ma nulla in realtà ti prepara adeguatamente alla visione di un Funny Games moltiplicato per 78 anni.
Due considerazioni: il documentario definisce alla perfezione i due attori sulla scena, con il popolo palestinese - i residenti eroi del villaggio di Masafer Yatta - che si staglia gigantesco, dando prova di una Resistenza, una pazienza, una resilienza di fronte al sopruso che hanno del soprannaturale. Il popolo eletto sono loro, se esiste qualcosa del genere. Capaci di resistere come rocce ed arbusti conficcati nella terra, con radici talmente vaste e profonde da poter essere estirpate solo causando un sisma globale, devastante.
L'altro attore, l'esercito ed i coloni di occupazione, appare scialbo nella sua miseria, inutile, animato da violenza cieca ed irrefrenabile, costretto a confrontarsi, senza successo, con il Bene in sé. Un popolo che vive nella sua terra, e che vuole restarci. Costretto a fare i conti in ogni momento della sua sciagurata permanenza in quella terra con i nativi, che sono lì per diritto naturale - con le loro kufiye, la gentilezza ed il senso di ospitalità, i loro abiti e gli occhi sgranati sulla banalità di un male che distrugge quello che di più sacro essi possiedano, un territorio altrimenti meraviglioso - quindi temuti ed odiati oltre ogni possibile immaginazione.
La seconda considerazione è rivolta agli apologeti del sette ottobre, i fiancheggiatori del crimine impunito in Palestina, gli ignavi, i megafoni in piccolo della narrativa tossica, coloro che ignorano. I miserabili. Tu invece esci dal cinema stravolto e ti chiedi perché , e secondo quale perversa logica, il sette di ottobre sia giunto così in ritardo. Come sia stato possibile per un popolo subire una tale violazione di ogni suo diritto senza che nessuno si ergesse mai in sua difesa - che è la difesa della legge internazionale e morale contro il sopruso del più forte - per settantotto lunghissimi anni.
È ciò su cui si interroga Yuval, il documentarista che aiuta Basel, palestinese di Masafer Yatta, a raccogliere il materiale sui crimini israeliani nei villaggi della West Bank , e la lezione che ne riceve è esemplare. Ci vuole sabr, amico mio, pazienza. La vittoria non arriva in un giorno e neanche in settant'anni. Noi possediamo il sumud e la capacità di resistere infinitamente. Loro distruggono e noi ricostruiamo, di notte, senza essere visti, mattone su mattone, con pochi mezzi, utilizzando ogni nostra risorsa residua. Affinando sensi e mente. Pregustando il frutto maturo della libertà mentre ci nutriamo di sangue e fango.
Il sumud ha regalato un Oscar ai due documentaristi dopo quattro anni di riprese nel mezzo dell'inferno. Voglio ricordare, a loro perenne onta e scuorno, le reazioni inviperite del sindaco di Berlino e di tanti politici tedeschi alla vittoria del documentario alla Berlinale dell"anno scorso. Sì dissociarono, accusarono Yuval e Basel di antisemitismo e definirono inaccettabile la vittoria.
L'apice del degrado fu raggiunto dal ministro della cultura Claudia Roth che, fotografata nell'atto di applaudire, si giustificò dicendo che il suo encomio era riservato al solo Yuval, israeliano, e non a Basel, palestinese.
VAI A TUTTE LE NOTIZIE SU GAZA
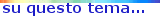 
Dossier
diritti
|
|

