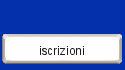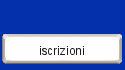|
"INTERNET
FRA LIBERTA' E DIRITTI:
prevenzione delle violazioni e prospettiva forense"
Internet
nella giurisprudenza
abstract dell'intervento di Elena FALLETTI*
Per inquadrare correttamente la natura di Internet occorre presentare
alcune considerazioni preliminari: Internet è una società c.d.
a "potere diffuso", perchè al suo interno non esiste un ente centralizzato
in grado di prendere il sopravvento sugli altri nella gestione
della regolamentazione e nella divulgazione di contenuti online.
Tale
peculiarità è dovuta alla struttura stessa della Rete, organizzata
seguendo i principi del c.d. "End to End Principle", una
struttura paritaria che utilizza nodi comunicanti tra loro.
Sotto un profilo giuridico la natura della Rete comporta che non
è possibile al momento né predisporre norme di natura positiva
valide per tutta la Rete, né dare efficacia a sentenze di giudici
nazionali su enti presenti in Rete afferenti ad ordinamenti diversi.
La soluzione adottata finora è di regolare le controversie secondo
le regole del diritto internazionale privato, ovvero nell'ambito
dell'Unione Europea secondo le norme adottate da questo ordinamento
sovranazionale e implementate negli Stati membri. Vi sono strumenti
pattizi di diritto internazionale, come i trattati del WIPO in
materia di protezione del diritto d'autore, tuttavia questi non
coprono tutte le problematiche di natura giuridica che possono
sorgere online.
Internet rappresenta una delle frontiere più avanzate nel dibattito
giuridico: essa, luogo del virtuale, si pone come un labirinto
di specchi deformanti dove può essere insieme molto divertente
ed altrettanto illusorio camminare e le caratteristiche innovative,
sempre diverse, del luogo hanno effetti immediati sui diritti
della personalità degli utenti. Essendo
la Rete virtuale uno specchio della vita reale attraverso di essa
si riflettono tutti i diritti coinvolti nella realizzazione umana,
tuttavia ve ne sono alcuni che ricorrono più di altri: tutela
della riservatezza, della dignità, della onorabilità, della libertà
di manifestazione del pensiero, dell'accesso alla cultura, della
proprietà e l'elenco potrebbe continuare perché l'evoluzione di
Internet coinvolge sempre maggiori aspetti della vita collettiva
e anche singolarmente di chi la usa.
Una
recente corrente della sociologia ha osservato come il fenomeno
di diffusione di massa della Rete abbia creato, nelle ultime generazioni
di utenti, la categoria dei "nativi digitali", ovvero di coloro
che interagiscono con le tecnologie informatiche e con Internet
fin dall'infanzia (J. Palfrey, U. Gasser, Born Digital, New York,
2008). Questa categoria si contrappone a quella degli "immigrati
digitali", cioè coloro che hanno subito la rivoluzione tecnologica
soltanto in età adulta e quindi avrebbero una percezione di tale
rivoluzione più legata alla realtà rispetto alla virtualità. Anche
se il dibattito su questa teoria è ancora molto acceso, essa si
può considerare quale parametro di verifica della crescente tendenza
al mutamento di approccio del mondo digitale da parte dei più
giovani.
La virtualità della Rete influisce non solo sull'avvicinamento
alla stessa da parte degli utenti, ma la trasformazione o per
lo meno l'adattamento dei concetti giuridici tradizionali collegati
alla protezione dei diritti fondamentali a questo tipo di ambiente.
Il primo diritto fondamentale materialmente coinvolto nell'uso
di Internet concerne la riservetezza, poiché inerente al collegamento
stesso dell'utente con la Rete attraverso il modem e l'attribuzione
di un Internet Protocol, cioè il dato numerico identificativo
collegato ad una rete informatica, paragonabile al di fuori del
cyberspazio ad un indirizzo stradale.
Il
punto principale concerne se la serie di numeri che formano l'Internet
Protocol sia da considerarsi un dato personale o meno. Si tratta
di una questione essenziale perché se l'IP è dato personale il
trattamento del medesimo deve essere sottoposto a tutte le garanzie
previste dalle vigenti normative convenzionali e comunitarie,
da ultima la Carta europea dei diritti fondamentali. Nel dibattito
internazionale dottrina e giurisprudenza sono divise. Ad esempio
negli Stati Uniti, in una recente decisione della Corte federale
distrettuale del Southern District of New York ha stabilito che
l'Internet Protocol non è diverso dallo User Id, cioè non è una
informazione sufficiente ad identificare con certezza quale sia
il soggetto cui esso si riferisce (United States District Court,
Southern District of New York, 07 Civ. 2103 (LLS), Viacom v. YouTube,
1 agosto 2008, p. 13 e ss).
La giurisprudenza comunitaria non ha ancora affrontato in modo
diretto cosa sia l'Internet Protocol e se sia da considerarsi
un dato personale, tuttavia è possibile rispondere affermativamente
a questo con una ricostruzione interpretativa proposta dalla Corte
di Giustizia (Corte di giustizia delle Comunità Europee, 19 febbraio
2009, C?557/07) la quale afferma che il fornitore di accesso a
Internet assegna ai propri clienti un indirizzo IP ("Internet
Protocol"), per lo più dinamico. Sulla base di quest'ultimo e
del periodo o momento preciso in cui esso è stato assegnato, il
provider è in grado di identificare un cliente. Si tratta di una
visione opposta rispetto a quella adottata dalla Corte federale
americana sopra citata.
La
medesima Corte di Giustizia, nella precedente causa Bodil Lindqvist
(Corte di giustizia delle Comunità Europee, 6 novembre 2003, C-101/01),
aveva sostenuto che "La nozione di "dati personali" accolta nell'art.
3, n. 1, della direttiva 95/46 comprende, conformemente alla definizione
che figura nell'art. 2, lett. a), di questa, "qualsiasi informazione
concernente una persona fisica identificata o identificabile".
Tale nozione ricomprende certamente il nome di una persona accostato
al suo recapito telefonico o ad informazioni relative alla sua
situazione lavorativa o ai suoi passatempi. Se così fosse, risulta
alquanto complicato negare che l'indirizzo fornito dal provider
all'utente per mezzo di una connessione telefonica non sia un
dato personale.
La
giurisprudenza costituzionale tedesca a questo proposito ha riconosciuto
cittadinanza, a fianco del diritto di habeas corpus, al diritto
di habeas data, ovvero l'esistenza del principio che ciascun fruitore
delle tecnologie telematiche ha diritto alla propria libertà digitale,
in quanto espressione di una personalità digitale e quindi anche
di un domicilio digitale dove si racchiudono le comunicazioni
digitali, siano esse raccolte in una casella di posta webmail
o nel laptop di uso quotidiano (BVerfG, 27 febbraio 2008, 1 BvR
370/07 - 1 BvR 595/07).
Va
però osservato come il più recente orientamento della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea abbia inteso garantire la peculiare
struttura della Rete, proprio in tema di bilanciamento tra diritti
fondamentali come l'accesso alla medesima Internet, la riservatezza,
il diritto di manifestare liberamente il pensiero, di accedere
alla conoscenza da un lato con le pretese patrimoniali della tutela
dei diritti d'autore. Infatti, ha statuito la Corte di giustizia
che occorre tenere "presenti le condizioni derivanti dalla tutela
dei diritti fondamentali applicabili" e che quindi le direttive
europee (nella specie la 2000/31/CE, relativa al commercio elettronico;
la 2001/29/CE, sulla protezione del diritto d'autore; la 2004/48/CE,
sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; la 95/46/CE,
in materia di protezione dei dati personali; la 2002/58/CE, relativa
alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), "devono
essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione ad un
fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di
filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano
per i suoi servizi, in particolare mediante programmi "peer-to-peer",
applicato a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue
spese esclusive, e senza limiti nel tempo, idoneo ad identificare
nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti
un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla
quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale,
onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi
il diritto d'autore" (Corte europea di giustizia, 24 novembre
2011, C-70/10, Scarlet v. Sabam). Tale decisione è essenziale
per ribadire il principio di neutralità della Rete.
Come
già accennato, sul piano tecnologico la Rete tende a svilupparsi
quale società a potere diffuso, in ogni caso la sua evoluzione
è più veloce e distribuita di una qualsiasi norma positiva di
formazione parlamentare, a meno che non intervenga altra tecnologia
in senso repressivo, ovvero la stesura di accordi di natura privatistica.
Sotto il profilo normativo si potrebbero proporre due modalità
operazionali: a) Quella relativa alle normazioni statali della
materia i quali presentano due problemi: essi riguardano solo
il settore della rete sottoposto a quella giurisdizione, e non
sono completamente condivisi dagli utenti; b) quella dell'Internet
Bill of Rights, che essendo proposta di regolamentazione di Internet
da adottarsi in modo unanime tra tutti gli operatori della Rete,
è rispettosa della sua natura di ente a potere diffuso, analogamente
alla principale tra le società a potere diffuso, cioè la comunità
internazionale. Seppur brevemente sarebbe interessante riflettere
sulle ripercussioni dell'uso di Internet e dei social network
su degli aspetti più intimi e comuni della personalità umana,
ovvero della vanità, in un certo senso dell'autostima e del bisogno
di essere accettati nella propria comunità e quindi dell'esposizione
di sé sui social network, in particolare Facebook.
Occorre sottolineare che attraverso i social network come Facebook
gli utenti consentono la mappatura delle proprie relazioni personali
e dei propri gusti individuali consentendo la raccolta di tali
dati sia sotto un profilo individuale sia collettivo dando ragione
a quella dottrina che parla di utenti "felici e sfruttati" (C.
Formenti, Felici e sfruttati, Milano, 2011) che offrono gratuitamente
e integralmente a società terze la propria personalità digitale.
Nel tentativo di elaborare strumenti concettuali al fine di arginare
questo fenomento sul web recentemente si sta diffondendo una teoria
interessante che lega la cittadinanza in Rete attraverso la proprietà
di un nome di dominio (A. Short, It's the end of the web as we
know it, 2011, http://adrianshort.co.uk/2011/09/25/its-the-end-of-the-web-as-we-know-it/):
si è cittadini di prima categoria quando si utilizzano hardware
e software propri insieme ad un nome di dominio intestato a sé
stessi. In questo caso, nel rispetto delle leggi, si è pienamente
liberi di disporre dei propri materiali e soprattutto dei propri
dati, anche se tutto ciò ha un costo, anche in denaro, spesso
non proprio alla portata di chiunque.
Nel caso in cui ci si appoggi a service provider per ospitare
i propri beni digitali, si è cittadini di seconda categoria, quasi
come se si fosse ospiti di un affittuario al quale comunque si
versa un canone di locazione. In questo caso è più difficile gestire
i propri materiali, ma è ancora possibile traslocare quando non
si è soddisfatti del servizio ottenuto per i denari versati. Il
terzo caso, quello più diffuso, è quello dei cittadini di terza
categoria, equiparabili a dei proletari, che fruendo gratuitamente
di servizi si vedono sottrarre la disponibilità su risorse essenziali,
sia per l'utente, che si vede profilare in tutti i lati della
sua personalità perdendone il controllo, sia per il service provider
che dai dati di ciascun utente, trattati complessivamente, può
delineare gli orientamenti del mercato. Tale situazione dà al
provider un doppio vantaggio: ridurre enormemente i margini di
rischio degli investimenti in nuovi prodotti da destinare al mercato
e dall'altro trarre enormi profitti dalle cessione a titolo di
lucro di tali dati.
E
all'utente proletario, cosa rimane? Oltre
alla difficoltà di rientrare in possesso (in questo caso non si
parla di proprietà) dei propri materiali (scritti, fotografie,
video) egli si trova sia nell'impossibilità fattuale di cambiare
il fornitore del servizio, poiché tutti i suoi contatti sono allocati
su quella piattaforma, con il rischio di perdere tutti i link,
i preziosi collegamenti, che aveva maturato nel corso della fruizione
del servizio. Come è possibile reagire di fronte a siffatta condizione?
Tra le decine di proposte regolatrici di Internet manca l'unica
che potrebbe consistere in una soluzione equilibrata di questo
rapporto asimmetrico, ovvero l'obbligatorietà della portabilità
del profilo individuale degli utenti (J. C. De Martin, Tipi, organizzazione
e modelli di business di social network, relazione presentata
al XX incontro di diritto industriale "Facebook et similia (profili
speciali dei social network), Pavia, Università degli Studi, 30
settembre - 1 ottobre 2011). Se realizzata, siffatta proposta
contribuirebbe a riconoscere il diritto di cittadinanza digitale
degli utenti della Rete, che diverrebbero titolari di diritti
e libertà fondamentali in modo più incisivo rispetto a quanto
non accada ora, poiché attraverso essa i cittadini digitali, non
più soltanto utenti, verrebbero chiamati all'adempimento dei loro
doveri, parte complementare ed essenziale del riconoscimento e
della rivendicazione dei diritti.
*
ricercatrice di Diritto comparato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università LIUC di Castellanza (VA).
GLI
ALTRI INTERVENTI ALLA CONFERENZA INTERNET FRA LIBERTA' E DIRITTI
|
|