 |
Diana
Blefari non si e' uccisa per 'colpire' ma perche' stava male
riceviamo
e pubblichiamo
L’ultimo pensiero di Diana Blefari potrebbe essere stato:
“Non mi uccido per morire ma per-essere”… per essere riconosciuta
dagli altri come soggetto. Non è stato un atto di guerra contro
la società di una brigatista, ma un atto di una donna detenuta
che stava male. Le condizioni descritte di psicopatologia
nelle varie agenzie non mi soddisfano, non del tutto: mi resta
il pensiero di come potrebbe essere stata la salute, e quindi
la vita, di Diana Blefari se non fosse stata per anni sottoposta
al regime del "carcere duro".
Dalla
nostra ricerca “Morire di carcere” emerge che nel quinquennio
2004-2008 le persone sottoposte al “carcere duro” si sono
uccise con una frequenza 90 volte superiore a quello della
popolazione libera! (Regime che alla Blefari era stato revocato
un anno e mezzo fa, ma che ha lasciato segni indelebili sul
suo equilibrio, come abbiamo potuto leggere in questi giorni).
Nelle
Sezioni di Alta Sicurezza, ad Elevato Indice di Sorveglianza,
all’isolamento del regime del 41-bis (due ore d’aria e due
di socialità al giorno, posta censurata e un’ora al mese con
la famiglia, attraverso un vetro), è il tempo che diventa
il maggior tormento, perché ad uno spazio immobile, strozzato,
corrisponde una dilatazione del tempo vuoto e di negazione
del tempo-per-sé. Diventa enorme, mostruoso, occupa tutto
lo spazio della cella e della tua testa. È un tempo senza
ritmo, con pensieri ossessivi che scandiscono in maniera allucinante
la vita carceraria.
Perché il carcere duro, si sa, priva le persone dell’orientamento
nella geografia dello spazio-tempo interiore, cioè della possibilità
di ri-conoscersi. Una modalità di scontare la pena che porta
la persona, in senso antropologico, ad essere scardinata nelle
sue dimensioni più umane e sociali, ad non avere riferimenti
nello spazio e nel tempo per determinarsi come identità. Una
identità che, con la condanna all’ergastolo, si arriva a concepire
come ferma al momento dell’arresto. Il suicidio rappresenta
la risposta, unica possibile, ad un dolore che aveva raggiunto
la soglia dell’insoffribile. Insomma ha scelto di morire-per-essere.
Una “scelta” che molte persone in carcere fanno, non per paura
del carcere, ma per paura di non-essere, cioè di morire “dentro”
se stessi.
Il
suicida è il disinganno della realtà trattamentale, delle
politiche di sicurezza, del lavoro dei magistrati. È il fallimento
dei diritti dell’uomo e della nostra democrazia perché noi,
qualsiasi di noi, che commette un reato ha diritto ad una
pena giusta, non ad un’applicazione della pena che diventa
“pena capitale”. In tale senso il suo è stato un comportamento
umano di risposta ad una condizione di “lesa umanità” quindi
non spiegabile neppure dal punto di vista psicologico e soprattutto
psicopatologico. E non serve solo indignarsi, è necessario
difendere i nostri diritti di giustizia, di democrazia, perché
oramai siamo stranieri a noi stessi, alle nostre leggi, al
nostro stesso sentire. E siamo il risultato di una oltraggiosa
violenza che noi stessi che, come società, alimentiamo.
Laura
Baccaro,
psicologa e criminologa
Centro Studi di Ristretti Orizzonti
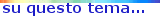 
Dossier
diritti
|
|

